Reportage/Inchiesta. SCUOLA E LIBERTÀ DI ESPRESSIONE (work in progress)
Reportage/Inchiesta.
SCUOLA E LIBERTÀ DI ESPRESSIONE
(work in progress)
di Elisabetta Berliocchi Bistarelli
N.B. Questo articolo ha la pretesa di essere al contempo "divulgativo" e "scientifico", usando un linguaggio che arrivi sia agli operatori di settore, che al grande pubblico.
Inizio da una parola-chiave, anzi due, e dalla mia esperienza diretta sul campo come persona, giornalista e docente curriculare, nel mio caso di Francese, di Storia dell'Arte e Territorio, di Educazione civica/Cittadinanza e Costituzione. Traggo il loro significato dall'Enciclopedia Treccani. INCLUSIONE. Una parola di origine latina (inclusio-onis). "- 1. a. L'atto, il fatto di includere, cioè di inserire, di comprendere in una serie, in un tutto (spesso contrapposto a ESCLUSIONE)." INCLUSIVITA'. "Termine con cui si designano in senso generale orientamenti e strategie finalizzati a promuovere la coesistenza e la valorizzazione delle differenze attraverso una revisione critica della categorie convenzionali che regolano l'accesso a diritti e opportunità, contrastando le discriminazioni e l'intolleranza prodotte da giudizi, pregiudizi, razzismi e stereotipi. [...] Il termine si è diffuso in Italia dagli anni Novanta del Ventesimo secolo soprattutto in ambito educativo e formativo, trovando nei decenni successivi vasta applicazione nella didattica scolastica per denotare strategie educative atte a rispondere alle necessità dell'intera popolazione studentesca, con priorità per i soggetti fragili, rispettando e valorizzando le differenze individuali e definendo competenze specifiche e forme di insegnamento multilivello e pluridisciplinari". Se questo fosse davvero applicato, mi permetto di osservare, nella percezione soggettiva del gruppo verrebbe accolta ogni diversità del singolo come un "plus valore" e non come "fragilità", e il "plus valore" comunemente riconosciuto non verrebbe svilito. E' quindi lungo questo binario che procederò nel redigere un testo organico, partito come reportage di viaggio, il viaggio nella scuola e nel mondo della formazione, e rivelatosi poi una vera e propria inchiesta, anticipata a mano a mano in modo frammentario via socials (Linkedin, Facebook, Instagram, Twitter/X, Whatsapp scuola) e tramite piattaforme di settore ufficiali (Registro elettronico: "Classe Viva" gruppo Spaggiari; Nuvola Madisoft + Google: meet, classroom...; webex; zoom...+ "carteggio" tramite account di posta elettronica: libero.it; g-mail; pec.it...), nel rispetto della deontologia e della normativa in vigore. Invito a rileggere attentamente e lentamente, per una piena comprensione e assimilazione, la definizione citata dei due lessemi, cioè vocaboli consultabili sul dizionario e sull' enciclopedia.
Non facciamo però l'errore di colpevolizzare unicamente i docenti. Noi genitori abbiamo in ogni caso la maggiore responsabilità. Mi piace qui citare la conclusione di un libro per l' infanzia rivolto agli adulti.
"I genitori sono responsabili della fiducia che i figli nutrono in sé stessi. Tramite il comportamento, possono fare sì che il loro bambino cresca diventando un adulto in grado di farsi strada nel mondo senza tenere conto dell'opinione degli altri. A tale scopo, i genitori mostrano al bambino la sua unicità, i suoi talenti e i suoi punti di forza speciali", scrive Alma Gross in Perché sei speciale.
È auspicabile che in aula, soprattutto davanti ai compagni, lo facciano pure gli insegnanti. Con ognuno. Senza distinzione di sorta. "Per farlo, è necessario distinguere la personalità del bambino dal suo comportamento". Fondamentale. "Un bambino non è mai cattivo, si comporta solo in modo sbagliato". E questo va fatto comprendere chiaramente, ma sempre senza umiliarlo o ledere la sua autostima. "Il prerequisito affinché ciò avvenga è che la comunicazione tra genitori e figli (maestri e allievi, ndr) si svolga su un piano di parità e che i sentimenti possano essere discussi in modo aperto e imparziale". Il che non vuol dire abdicare al proprio ruolo genitoriale di guida, che talvolta presuppone fermezza, bensì instaurare un dialogo continuo e autentico. Dialogo fondato sull'amore (usiamola, questa parola: è anche per amore dei discenti, oltre che per la propria materia, che si fa docenza), sul rispetto e sulla fiducia reciproci, che permetta la conoscenza delle situazioni che si trova a vivere la persona di fronte a noi, le ripercussioni che i fatti hanno su di lui, e consenta un intervento opportuno, in caso di bisogno, per necessità legate alla crescita, alla psicologia dell'età evolutiva e alla piena, sana, affermazione di sé. E qui ci viene incontro la Costituzione italiana!
Che dice l' Articolo 2 dei Principi Fondamentali? "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale". E l' Articolo 3 della nostra Costituzione che dice? "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, sociale ed economica del Paese". Ebbene, gli studenti sono dei lavoratori. Il loro lavoro è andare a scuola e studiare. Potranno un giorno persino riscattare gli anni di studio universitari ai fini pensionistici. Intanto, a scuola si va e a scuola (scuola dell'obbligo e oltre) si sta. E bisogna starci bene. Quindi, se da una parte gli alunni sono obbligati a tenere un comportamento rispettoso e consono all'istituzione che frequentano, dall'altra un docente, pubblico ufficiale, deve rendere effettivi questi diritti. Di più, deve far sì che in aula si stia bene, si possa apprendere in tutta serenità e nel migliore dei modi possibili. Provarci, quanto meno, con tutte le sue forze. Purtroppo però questo non è "il migliore dei mondi possibili" come direbbe il Candide di Voltaire. Nonostante la buona volontà, tante sono le componenti che recano danno al buon vivere in aula. E qui subentra anche il ruolo dei colleghi, dei compagni, dei genitori. Sembra paradossale ma è proprio tra i banchi di scuola che si fa sentire la nostra pesante influenza. Come? È presto detto. Ognuno di noi, insegnanti inclusi, porta con sé un bagaglio di viaggio: esperienze, convinzioni, pregiudizi, metodo, informazioni e conoscenze, punti di riferimento...che inevitabilmente incidono sui rapporti di interazione tra docenti-alunni-famiglie. Una delle battaglie quotidiane da svolgere costantemente a scuola è tenere fuori dall'edificio scolastico ingerenze che lì non hanno ragione di esistere. Bambini, ragazzini e ragazzi sono "spugne" e talvolta assorbono ciò che non dovrebbero. E fin qui "ho scoperto l'acqua calda". Dov'è che si passa dalla semplice riflessione, frutto di buon senso, all'azione? Sul campo. Ecco perciò che la presenza/posizione (scomoda) di un giornalista a scuola si configura come testimonianza di un professionista (e quante energie sprecate a screditarne in corso d'opera l'operato!!), nell'esercizio e nella veste duplice di docente e reporter, magari con un figlio in piena età scolare. In bilico tra interesse degli alunni e dell'istituzione scolastica, deontologia professionale, normativa vigente, diritti/doveri e, last but not least, la propria coscienza. Un "gioco" di equilibri estremamente delicato, e in alcuni casi pericoloso, perché un gioco non è.
E pensate un po' dove insegno, in questo autunno 2024? All' "Istituto Comprensivo Assisi 1 e Scuola per Ciechi". Di fatto all' Istituto Serafico dove ha sede, al terzo piano. Convocazione da graduatorie GPS docenti di FRANCESE. Contratto fino al 30 giugno. La scuola Secondaria di I grado e la Primaria esistevano già da 6 anni, mi riferiscono i referenti di plesso, ma è da quest'anno scolastico 2024-2025 che la "SCUOLA SPECIALE" (così c'è scritto fuori dalla porta e su certi documenti digitali e cartacei) è stata accorpata all' IC ASSISI 1. Gli alunni sono per lo più esterni che arrivano e restano per la durata dell'orario scolastico. Scuola speciale...un nome che personalmente mi fa venire i brividi. È "un mondo a parte", sebbene si stia andando nella direzione di parziale inclusione. Non ho mai accettato incarichi come insegnante di sostegno, non reputandomi all'altezza. In questa occasione, sembra incongruente ma non lo è, sono stata chiamata qui come docente di lingua, insieme ad altri di inglese, matematica, italiano, tecnologia, educazione fisica, arte e attività pratiche speciali (i veri competenti di settore). Una sfida. Un libro quasi bianco su cui scrivere e colorare. Con tanti convinti che qui non si possano insegnare discipline come francese, inglese... e, a distanza, altrettanti che plaudono all'iniziativa, all' "apertura delle porte" e ad un piano di studi siffatto più in linea con quello della scuola dell'obbligo, sebbene per il programma ministeriale di ogni materia, va da sé, debba essere adattato alla situazione reale e contingente, studiando e mettendo in atto percorsi che partano dalle potenzialità di ogni studente.
Intanto vi tengo aggiornati di volta in volta via social. Per il resto...si vedrà!
Procedo, nel mentre, con l'inchiesta-reportage nel mondo della scuola, avendo come filo conduttore quanto progettato a suo tempo.
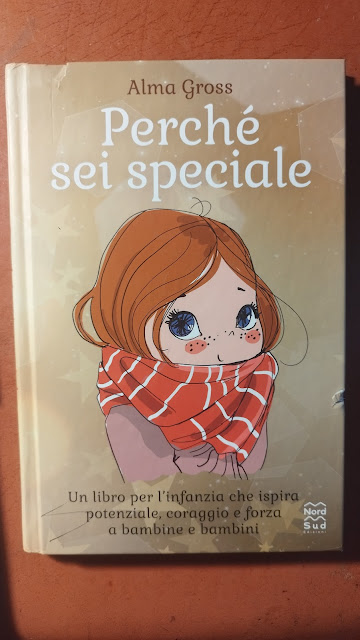


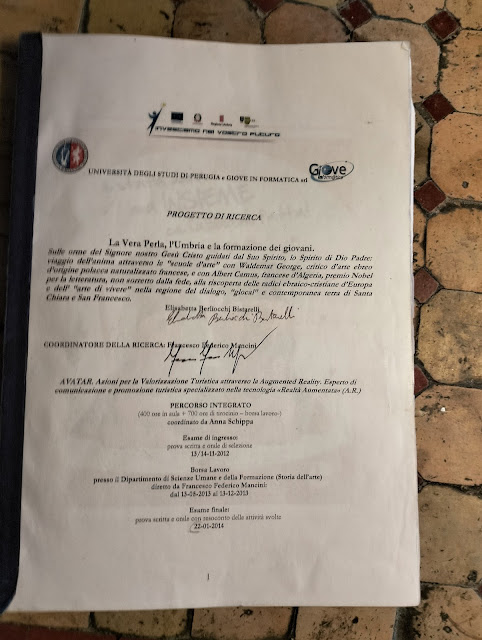
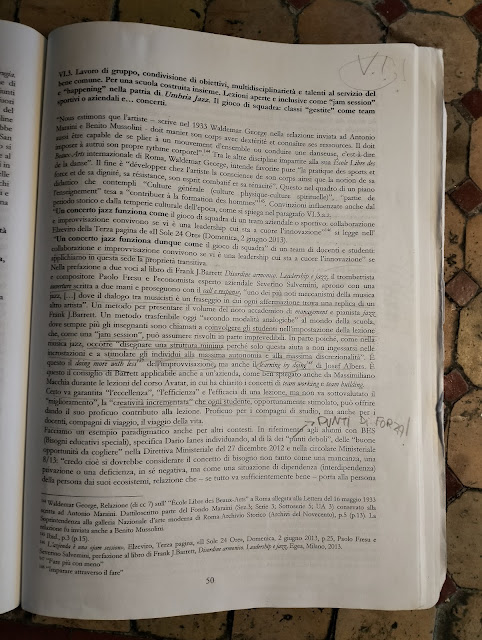
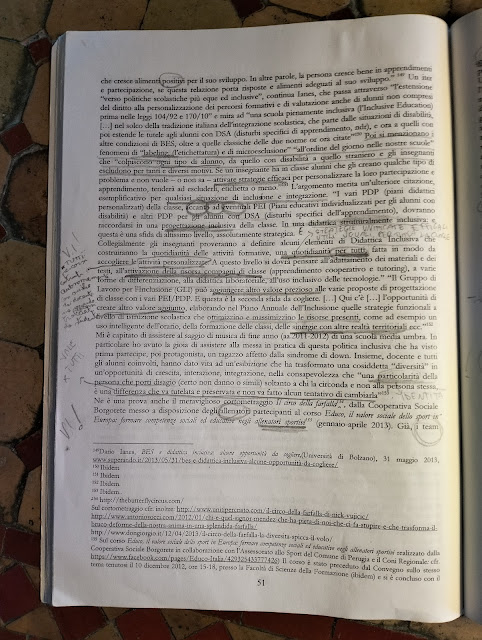





Commenti
Posta un commento